È CON VERO PIACERE CHE ACCOGLIAMO SU QUESTE PAGINE
ELETTRONICHE UNA NOSTRA NUOVA COLLABORATRICE: MANUELA SIMEONI. VI PRESENTIAMO IL
SUO PRIMO LAVORO… UN INTERESSANTE ARTICOLO SULLA FIGURA DEGLI ANTICHI
GLADIATORI. TROVERETE MOLTE SIMILITUDINI ED ACCOSTAMENTI AI PIU’ NOTI
PERSONAGGI DEI NOSTRI AMBIENTI SPORTIVI. UN ARTICOLO CHE MOSTRA TUTTA LA SUA
AUTOREVOLE PREPARAZIONE SULL’ARGOMENTO… E CHE CI AUGURIAMO SIA IL PRIMO DI
UNA LUNGA SERIE.
I GLADIATORI
Di: Manuela Simeoni
(foto tratte fal film
"Il gladiatore")
 Portata
alla ribalta qualche anno fa dal film con Russell Crowe, la figura del
gladiatore è sempre stata particolarmente interessante per chi, in Europa, si
identificasse, in un modo o nell’altro con l’immagine del guerriero. Da
atleti (non solo praticanti di arti marziali) a manager rampanti, ai numerosi
club di tifosi che ne prendono il nome, in molti hanno subito il fascino di
questi “sportivi” dell’antichità, tanto che oggi esistono, ovviamente
soprattutto a Roma, alcuni gruppi storici che ne studiano il modo di combattere
e si allenano per riprodurlo. Purtroppo però, al di là di questi gruppi seri,
i gladiatori sono stati spesso raccontati in maniera da accentuare il lato
“esotico” e affascinante della loro professione, nei film come in alcuni
libri di argomento storico… Ma è appunto con il film “Il gladiatore” che
rinasce un poco, non solo il mito ma anche la voglia di saperne di più sui
gladiatori, al di là del film stesso. E nella storia si trovano caratteristiche
forse più interessanti del mito medesimo. Portata
alla ribalta qualche anno fa dal film con Russell Crowe, la figura del
gladiatore è sempre stata particolarmente interessante per chi, in Europa, si
identificasse, in un modo o nell’altro con l’immagine del guerriero. Da
atleti (non solo praticanti di arti marziali) a manager rampanti, ai numerosi
club di tifosi che ne prendono il nome, in molti hanno subito il fascino di
questi “sportivi” dell’antichità, tanto che oggi esistono, ovviamente
soprattutto a Roma, alcuni gruppi storici che ne studiano il modo di combattere
e si allenano per riprodurlo. Purtroppo però, al di là di questi gruppi seri,
i gladiatori sono stati spesso raccontati in maniera da accentuare il lato
“esotico” e affascinante della loro professione, nei film come in alcuni
libri di argomento storico… Ma è appunto con il film “Il gladiatore” che
rinasce un poco, non solo il mito ma anche la voglia di saperne di più sui
gladiatori, al di là del film stesso. E nella storia si trovano caratteristiche
forse più interessanti del mito medesimo.
L’origine stessa di questi
spettacoli appare poco chiara agli occhi degli storici: da dove li presero i
Romani? Il primo spettacolo gladiatorio a Roma fu organizzato nel
264 a
.C. da Marco e Decimo Bruto in onore del padre e in occasione dei funerali di
quest’ultimo, una specie di dono (che in latino si dice munus, e il cui
plurale, munera, indicherà a lungo i giochi gladiatori, ben distinti dagli
altri ludi, giochi, come ad esempio le corse dei cavalli) al defunto. Ma
l’origine dei giochi non è romana: lo storico Tito Livio scrive che i primi
giochi gladiatori in assoluto, furono organizzati dai Campani nel
310 a
.C., in occasione di una vittoria contro i Sanniti, ottenuta grazie all’aiuto
romano. Gli spettacoli gladiatorii avevano dunque un intento celebrativo e
quindi, come tutte le celebrazioni dell’antichità, un risvolto religioso.
Nelle stesse occasioni, come leggiamo nell’Iliade, i Greci sacrificavano, cioè
eseguivano in maniera rituale la condanna a morte, dei prigionieri di guerra: lo
fa Achille in occasione dei funerali di Patroclo, sgozzando alcuni prigionieri
troiani. Il combattimento tra gladiatori potrebbe essere quindi una sorta di
evoluzione di queste condanne a morte rituali e in occasione di funerali: lo
prova anche il fatto che uno degli spettacoli dei gladiatori era il
combattimento contro animali feroci e che presso gli Etruschi, il combattimento
contro l’animale era una modalità di esecuzione della pena capitale.
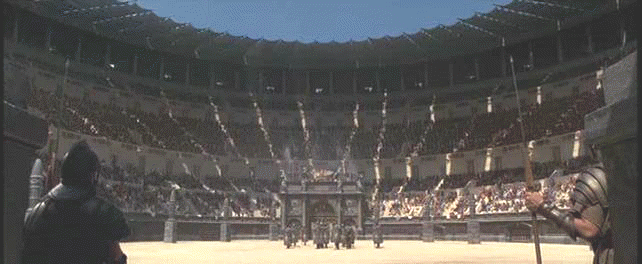
Ma allora da dove vengono i
giochi gladiatorii? Gli storici sono ancora indecisi tra un’origine
osco-sannita (anche i Campani che organizzarono i giochi del 310 a.C.
appartenevano al gruppo etnico osco, che è quello dei Sanniti), a favore della
quale deporrebbe anche l’antichità di una delle categorie di gladiatori, i
cosiddetti Samnites, di cui parlerò dopo, e un’origine etrusca dei giochi, a
favore della quale vi sono invece le pitture nelle tombe e la parola che
designava l’allenatore-proprietario del gladiatore, lanista (plur. lanistae),
parola etrusca che significa letteralmente “macellaio”. Sia Etruschi che
Campani e Sanniti, potrebbero aver preso questo costume dai Greci; ma è
comunque a Roma e nei suoi territori che lo spettacolo dei gladiatori giunse al
suo sviluppo massimo. Dal
105 a
.C. in poi questo cessò di essere relegato esclusivamente ad un ambito
religioso e privato e venne organizzato senza uno specifico intento celebrativo.
Massima fortuna ebbe poi in età imperiale.
 I
gladiatori che scendevano nell’arena erano di varia estrazione sociale e non
semplicemente degli schiavi come forse si è abituati a pensare. Molti erano i
gladiatori schiavi, che ottenevano la libertà dopo dieci vittorie, ma vi erano
anche prigionieri di guerra e criminali, liberati dopo tre o cinque anni, e
persone che sceglievano volontariamente di diventare gladiatori, nonostante
questo mestiere fosse bollato dalla legge come infamis, infame. Questo marchio
era dovuto forse al fatto che i Romani consideravano i gladiatori alla stregua
degli attori teatrali, altro mestiere non ben considerato. Augusto proibì a
tutti i membri della classe dei senatori e di quella dei cavalieri, di entrare
in un ludus (in questo caso la parola indica una scuola per gladiatori) e di
scendere nell’arena, ma già Caligola e Nerone vollero che alcuni membri di
entrambi gli ordini prendessero parte agli spettacoli. In età imperiale vi
furono anche gladiatrici donne, prima che Settimio Severo proibisse loro di
combattere nel 200 d.C.. Ma per le donne probabilmente non era previsto
l’allenamento in un ludus. Queste scuole per gladiatori, un misto tra un
centro sportivo e una caserma, erano fondate da un privato (almeno fino
all’epoca imperiale, quando le scuole di gladiatori passarono in mano
all’imperatore, per evitare che un privato si costruisse, dietro questa
facciata, un esercito personale) e dirette da uno o più lanistae, allenatori e
proprietari dei gladiatori, che sottoponevano ad un addestramento molto duro,
che prevedeva anche punizioni corporali, applicate nell’esercito solo a chi
non era cittadino romano, perciò in qualche modo i gladiatori, di qualsiasi
provenienza fossero, non erano comunque considerati cittadini, a causa del
mestiere che svolgevano. L’addestramento era a base di figure, come i moderni
kihon (fondamentali) e ren raku waza (tecniche combinate) del karate, tanto che
qualche spettatore si lamentava che certi gladiatori combattevano troppo
meccanicamente, cioè applicando le combinazioni che erano state loro insegnate
a scuola). Finito l’addestramento, i gladiatori erano raggruppati in compagnie
come i soldati, e le compagnie erano di proprietà dell’imperatore. Al di là
dei condannati a morte, che però probabilmente non venivano allenati ed erano
gettati nell’arena, di solito contro animali feroci, senza armi, in una sorta
di esecuzione rituale che si trovava già presso gli Etruschi, ogni gladiatore
riceveva l’armamento che più si adattava alle sue caratteristiche fisiche. In
base alle armi, i gladiatori si dividevano in diversi tipi: I
gladiatori che scendevano nell’arena erano di varia estrazione sociale e non
semplicemente degli schiavi come forse si è abituati a pensare. Molti erano i
gladiatori schiavi, che ottenevano la libertà dopo dieci vittorie, ma vi erano
anche prigionieri di guerra e criminali, liberati dopo tre o cinque anni, e
persone che sceglievano volontariamente di diventare gladiatori, nonostante
questo mestiere fosse bollato dalla legge come infamis, infame. Questo marchio
era dovuto forse al fatto che i Romani consideravano i gladiatori alla stregua
degli attori teatrali, altro mestiere non ben considerato. Augusto proibì a
tutti i membri della classe dei senatori e di quella dei cavalieri, di entrare
in un ludus (in questo caso la parola indica una scuola per gladiatori) e di
scendere nell’arena, ma già Caligola e Nerone vollero che alcuni membri di
entrambi gli ordini prendessero parte agli spettacoli. In età imperiale vi
furono anche gladiatrici donne, prima che Settimio Severo proibisse loro di
combattere nel 200 d.C.. Ma per le donne probabilmente non era previsto
l’allenamento in un ludus. Queste scuole per gladiatori, un misto tra un
centro sportivo e una caserma, erano fondate da un privato (almeno fino
all’epoca imperiale, quando le scuole di gladiatori passarono in mano
all’imperatore, per evitare che un privato si costruisse, dietro questa
facciata, un esercito personale) e dirette da uno o più lanistae, allenatori e
proprietari dei gladiatori, che sottoponevano ad un addestramento molto duro,
che prevedeva anche punizioni corporali, applicate nell’esercito solo a chi
non era cittadino romano, perciò in qualche modo i gladiatori, di qualsiasi
provenienza fossero, non erano comunque considerati cittadini, a causa del
mestiere che svolgevano. L’addestramento era a base di figure, come i moderni
kihon (fondamentali) e ren raku waza (tecniche combinate) del karate, tanto che
qualche spettatore si lamentava che certi gladiatori combattevano troppo
meccanicamente, cioè applicando le combinazioni che erano state loro insegnate
a scuola). Finito l’addestramento, i gladiatori erano raggruppati in compagnie
come i soldati, e le compagnie erano di proprietà dell’imperatore. Al di là
dei condannati a morte, che però probabilmente non venivano allenati ed erano
gettati nell’arena, di solito contro animali feroci, senza armi, in una sorta
di esecuzione rituale che si trovava già presso gli Etruschi, ogni gladiatore
riceveva l’armamento che più si adattava alle sue caratteristiche fisiche. In
base alle armi, i gladiatori si dividevano in diversi tipi:

-
Samnites,
Sanniti, con uno scudo lungo, una protezione alla gamba sinistra, un elmo
con visiera e una cresta con piume e la spada
-
Thraces,
Traci, con la protezione su entrambe le gambe, uno scudo piccolo quadrato,
un elmo con visiera completa (o con un ampio orlo) e una spada tracia,
ricurva con una piega angolata a metà della lama
-
Secutores,
Persecutori, quasi nudi ad eccezione della protezione alla gamba sinistra e
sui polsi e sui gomiti, avevano un elmo rotondo o con visiera alta, uno
scudo grande, ovale o rettangolare e una spada o una daga; sono
un’evoluzione dei samnites e combattevano di solito contro i retiarii.
L’imperatore Commodo era tra questi.
-
Retiarii,
Portatori di rete, avevano una veste ai fianchi, una protezione in metallo
sulla spalla sinistra fino al gomito, una daga, un tridente o un arpione e
una rete
-
Laquearii,
Portatori di laccio, avevano lo stesso armamento dei Retiarii con un laccio
al posto della rete
-
Galli,
in età imperiale chiamati murmillones, con un caratteristico elmo a forma
di pesce e armati per il resto come i secutores. Combattevano in genere
contro i thraces o gli hoplomachi
-
Hoplomachi,
Combattenti con lo scudo, che avevano un piccolo scudo rotondo, una lancia e
una spada corta e dritta.
-
Essedarii,
che combattevano, o forse entravano soltanto nell’arena su carri da
guerra, alla maniera dei Celti Britannici, forse introdotti da Giulio Cesare
-
Equites,
che entravano in arena sui cavalli, ma pare che poi combattessero a piedi
-
Velites,
con la lancia attaccata ad un cinturino, che poteva essere assicurato al
polso, ma tolto se il gladiatore lanciava la sua arma.
-
Sagittarii,
con arco e frecce
-
Dimachaeri,
con due spade
-
Provocatores,
Sfidanti, con una corazza, un elmo senza cresta, uno scudo rettangolare
curvo e una spada dritta
 All’inizio
le categorie erano solo tre, Samnites, Galli, e Thraeces, gli altri si
aggiunsero in seguito soprattutto in età imperiale quando fiorirono questi
giochi. I gladiatori combattevano con gladiatori di categorie diverse e, come già
detto, anche contro animali. Un particolare tipo di spettacolo era quello in cui
l’elmo dei due combattenti non permetteva loro di vedere, costringendoli a
combattere alla cieca. All’inizio
le categorie erano solo tre, Samnites, Galli, e Thraeces, gli altri si
aggiunsero in seguito soprattutto in età imperiale quando fiorirono questi
giochi. I gladiatori combattevano con gladiatori di categorie diverse e, come già
detto, anche contro animali. Un particolare tipo di spettacolo era quello in cui
l’elmo dei due combattenti non permetteva loro di vedere, costringendoli a
combattere alla cieca.
Gli spettacoli erano organizzati
da privati, sia quando avevano carattere celebrativo, sia in seguito, quando
persero questa caratteristica e divennero un munus (dono) non più ad un
defunto, ma al popolo. Il privato in questione “noleggiava” i gladiatori da
uno o più lanistae e pagava un certo prezzo per ciascuno; se il gladiatore
tornava ferito in maniera invalidante o morto, il prezzo era notevolmente alto.
In età imperiale fare uccidere i gladiatori nell’arena era quindi un modo,
per chi offriva lo spettacolo, di dimostrare la propria generosità… che lo
portava a non badare a spese pur di soddisfare il pubblico. Questo era
importante perché lo spettacolo era di solito una forma di propaganda
elettorale, con cui il candidato dimostrava di volersi occupare anche del
divertimento della gente. Secondo alcuni storici, nel primo periodo dei giochi
gladiatorii la probabilità di un gladiatore di essere ucciso era di una su
dieci, ma in età imperiale un gladiatore aveva un’aspettativa di vita di tre
o cinque anni, anche se combatteva due o tre volte all’anno. Quest’ultima
affermazione va considerata attentamente, perché si conoscono nomi di parecchi
gladiatori che sopravvissero fino alla “pensione” o almeno per diventare
essi stessi dei lanistae.

I giochi erano annunciati da
scritte rosse sui muri della città, antenate dei cartelloni moderni; a tutti è
nota, attraverso la miriade di film che l’hanno rappresentata, l’iconografia
del combattimento di gladiatori in età imperiale.
I gladiatori entravano
nell’arena, si disponevano in fila di fronte al palco imperiale (o di chi
aveva offerto lo spettacolo) e lo salutavano con la tradizionale formula
“morituri te salutant”, ovvero “quelli che stanno per morire ti
salutano”, una formula rituale con cui i combattenti dichiaravano di essere
disposti a combattere fino alla morte. Si tiravano a sorte le coppie di
combattenti e un arbitro controllava, come sui tatami o sui ring moderni, che le
armi fossero in regola. Cominciava dunque il combattimento, tra gladiatori di
categorie diverse, preceduto o seguito dalle venationes, ovvero gli spettacoli
contro animali (anche queste erano una forma più scenografica del sacrificio
abituale che dava inizio agli spettacoli e consacrava l’arena) e accompagnato
da dei musicisti. Sempre i film ci hanno insegnato che, quando un gladiatore
cadeva ferito e incapace di difendersi, era il pubblico a decretarne il destino.

Ma i film non sono la
realtà: innanzitutto il gladiatore sceglieva se morire o appellarsi al
pubblico, alzando un dito; in secondo luogo, almeno nei primi spettacoli, per
ragioni di risparmio, si contrattava precedentemente con i gladiatori e i
lanistae che non ci fossero combattimenti a morte. La decisione sarebbe spettata
teoricamente all’organizzatore dello spettacolo, ma essendo questo un veicolo
di propaganda, la scelta era demandata al pubblico, il quale gridava
“iugula” (sgozzalo) oppure “mitte” (lascialo); non si può però essere
sicuri dei gesti che accompagnavano queste parole: tutti sanno che il pollice
verso l’alto significava la grazia per il ferito e il pollice verso il basso
ne decretava la morte, eppure non abbiamo indizi storici che lo provino
chiaramente, anzi vi sono testimonianze per cui sarebbe esattamente il
contrario, con il pollice verso l’alto (o verso il proprio petto) a
simboleggiare la lama che entra nel corpo dell’avversario e il pollice verso
il basso (o i fazzoletti sventolati) a invitare il vincitore a deporre a terra
la spada.

In ogni caso, se il verdetto era
favorevole allo sconfitto, questo riceveva cure mediche tra le migliori in tutta
la città. Altrimenti afferrava la coscia dell’avversario per permettere al
vincitore di sferrare il tradizionale colpo al collo. I cadaveri erano portati
via da degli incaricati in costume, uno vestito da Caronte e l’altro da
Mercurio Psicopompo, che verificavano l’effettiva morte e, se era il caso,
davano il colpo di grazia (ma questo poteva essere dato negli spogliatoi, una
volta portato via il ferito dall’arena). Altri incaricati trascinavano via i
cadaveri con degli uncini. Il vincitore riceveva invece una fronda di palma,
tenendo la quale faceva il giro dell’arena, e un simbolo di vittoria, come una
moneta d’oro, una coppa dorata o una corona. Se non era il suo primo
combattimento era ben pagato; se si trattava di uno schiavo, indossava un
collare di ferro su cui erano segnate con delle tacche le vittorie conseguite: a
dieci otteneva la libertà, ma spesso continuava a fare comunque il gladiatore.
 Nonostante
il pericolo, la vita dura e il marchio di infamia, sempre più uomini liberi
entravano a far parte delle schiere dei gladiatori e i combattimenti tra uomini
liberi erano preferiti a quelli tra schiavi, come testimonia Petronio nel
Satyricon. Il gladiatore era comunque un mestiere, riceveva una buona paga, dal
secondo combattimento in poi, un’ottima assistenza medica e tre pasti al
giorno, che potevano essere un enorme passo in avanti per alcuni, soprattutto
nelle province o per gli strati più poveri. Anche se l’addestramento era
duro, i gladiatori, una volta addestrati non erano mai legati, incatenati o
confinati nei propri alloggi; ad essere costantemente sorvegliati erano soltanto
i novizi, o i più indisciplinati. In più, nonostante il marchio legale
d’infamia, i gladiatori, a differenza dei loro allenatori che erano
considerati vili speculatori, erano ben considerati nella società, ammirati
come gli atleti moderni soprattutto dalle donne (dai graffiti pompeiani sappiamo
di Celado e altri definiti “gloria e sospiro delle ragazze” o “adorati da
tutte le donne”). Alcuni gladiatori divennero amanti di ricche matrone e
vedove e si dice che persino Commodo non fosse figlio dell’imperatore Marco
Aurelio (che tra l’altro emanò alcune leggi a tutela dei gladiatori
nell’arena) ma dell’amante di sua madre, appunto un gladiatore. Nonostante
il pericolo, la vita dura e il marchio di infamia, sempre più uomini liberi
entravano a far parte delle schiere dei gladiatori e i combattimenti tra uomini
liberi erano preferiti a quelli tra schiavi, come testimonia Petronio nel
Satyricon. Il gladiatore era comunque un mestiere, riceveva una buona paga, dal
secondo combattimento in poi, un’ottima assistenza medica e tre pasti al
giorno, che potevano essere un enorme passo in avanti per alcuni, soprattutto
nelle province o per gli strati più poveri. Anche se l’addestramento era
duro, i gladiatori, una volta addestrati non erano mai legati, incatenati o
confinati nei propri alloggi; ad essere costantemente sorvegliati erano soltanto
i novizi, o i più indisciplinati. In più, nonostante il marchio legale
d’infamia, i gladiatori, a differenza dei loro allenatori che erano
considerati vili speculatori, erano ben considerati nella società, ammirati
come gli atleti moderni soprattutto dalle donne (dai graffiti pompeiani sappiamo
di Celado e altri definiti “gloria e sospiro delle ragazze” o “adorati da
tutte le donne”). Alcuni gladiatori divennero amanti di ricche matrone e
vedove e si dice che persino Commodo non fosse figlio dell’imperatore Marco
Aurelio (che tra l’altro emanò alcune leggi a tutela dei gladiatori
nell’arena) ma dell’amante di sua madre, appunto un gladiatore.
Anche nell’antichità come
oggi, quindi, il mito del gladiatore era vivo tra la gente: tra gli spettatori
dell’arena, che ne ammiravano l’abilità, e tra la gente che cercava di
diventarlo (come oggi si può desiderare di diventare atleti di successo) e che
trovava nella scuola dei gladiatori un ambiente duro sì, ma dove vigevano un
codice d’onore e uno spirito cameratesco di fratellanza che forse era
determinante nella scelta di molti di questi individui, soprattutto quando, ex
schiavi o ex criminali liberati grazie alle proprie vittorie, decidevano di
rimanere comunque tra i compagni e continuare a combattere. Onore e valore erano
cardini del modo di pensare dei gladiatori, non esisteva il fuggire dalla
battaglia e addirittura i gladiatori appartenenti alla categoria dei
Provocatores erano considerati vili dagli altri gladiatori, perché erano gli
unici a indossare la corazza, mentre gli altri combattevano a petto nudo. Gli
stessi valori sono presenti oggi nelle arti marziali, così come lo spirito
quasi di fratellanza che spesso si instaura tra i praticanti di una stessa
palestra o dojo o sala d’armi.

|